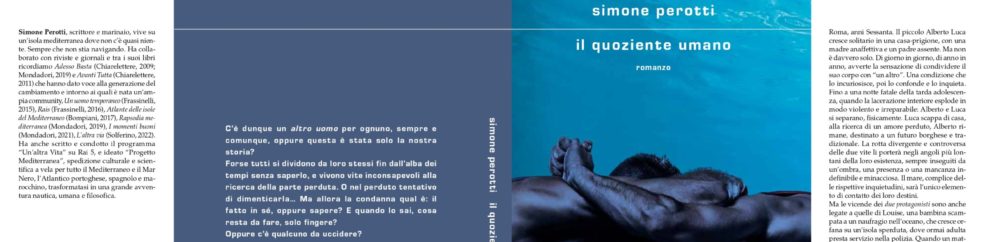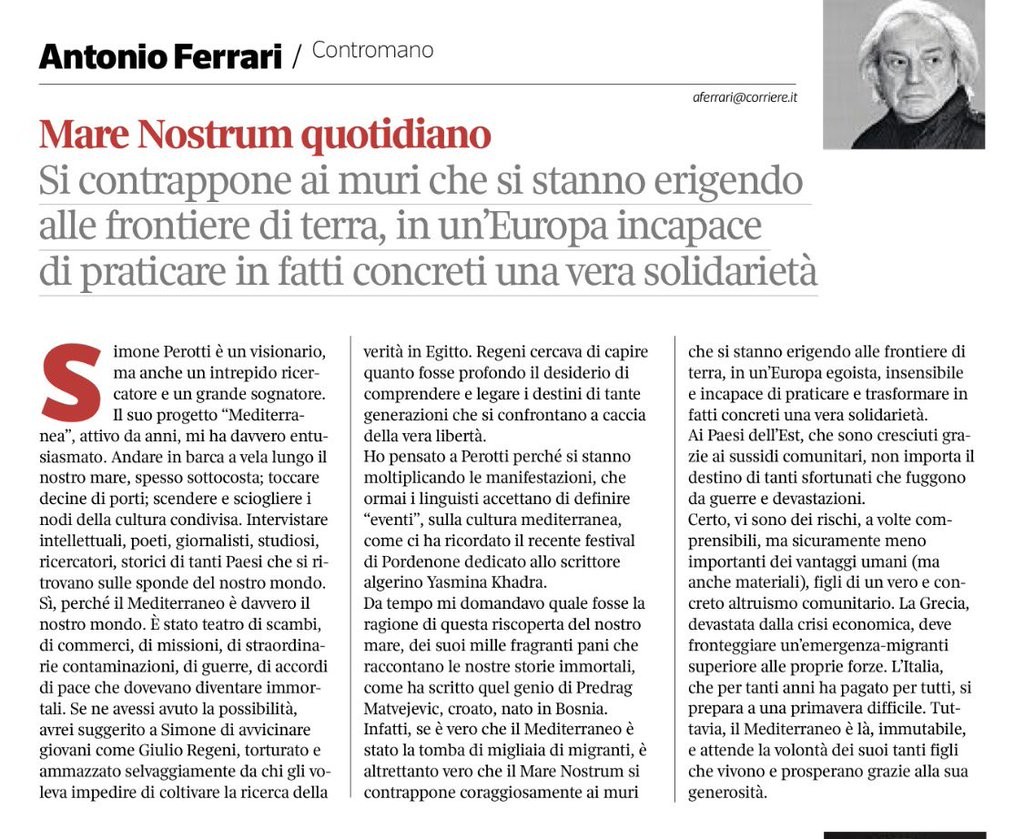Ruhollah e Perisa. Afgani. Persone.
Tra i migranti sul confine greco-turco.
Mitilene, Lesvos, Grecia, 22 settembre 2015
Luce di piombo sul porto, aria di scirocco distratto, che appiccica i vestiti addosso. Un peso invisibile sul cuore di questa linea di confine, dove sui muri trovi le offerte di lezioni di turco, dovunque locali di kebab e dove i capitali anatolici hanno costruito un marina molto attrezzato e gestiscono gran parte degli alberghi.
La cittadina è invasa di stranieri. Un esercito silenzioso, che sciama per il lungomare, l’angiporto, e si raduna sul molo, tra tende e bivacchi. “Aspettiamo il traghetto di questa sera”, mi dice Alis, “abbiamo già i biglietti”. Me li mostra con una certa soddisfazione.
Poco fa mi sono avvicinato alla zona occupata, lentamente, con qualche angoscia. Volevo parlare con loro, i migranti che riempiono le pagine dei quotidiani. Volevo entrare in contatto, rompere il muro. Sono radunati tutti nella parte orientale della città, assiepati sulla banchina principale, oppure a gruppi o isolati sull’estremità di un molo, con lo sguardo all’orizzonte, verso la terra turca lasciata da poco. Chi devo fermare, mi chiedevo, a chi devo rivolgere la parola per fare qualche domanda?
Il più, per decidere, l’hanno fatto gli occhi. E’ bastato smettere di non guardarli, come avevo fatto un giorno fa. Un misto di rispetto e paura, di ritegno e timore, uno giustificato, l’altro no. Dopo una decina di passi, subito un sorriso, un cenno d’intesa: “Prego, siediti” mi dice Alis, ventotto anni, siriano di Aleppo, studente di scienze della nutrizione, con occhiali un po’ storti, rotti in una estremità, e un sorriso persistente sulle labbra. Mi accomodo sulla stuoia a bordo molo, mi presento, offro qualche sigaretta. Sono in otto, tre sono amici, gli altri si sono conosciuti in viaggio. Uno di loro lavora, fa il fabbro, gli altri studiano economia, ingegneria, storia. Tutti parlano un discreto inglese. “Lui è di Damasco, io e gli altri di Aleppo. Sempre se esiste ancora Aleppo…”. Mi parlano della città distrutta, delle violenze, dei bombardamenti in ogni angolo del paese, visti di persona o saputi da amici e famigliari. “Non si può più vivere laggiù, siamo dovuti partire”. Come avete fatto a passare il confine turco? “Ci hanno accompagnato dei frontalieri. Quasi mille dollari a testa. Di notte. Ci hanno radunato in una casa e poi ci siamo mossi. Abbiamo camminato ininterrottamente per ventiquattro ore. Qualcuno non ce l’ha fatta e si è staccato, seduto per riposarsi. Ma i frontalieri sono andati avanti, e noi li abbiamo seguiti. Tutta in salita, sulle montagne, e poi giù a strapiombo”. Gli chiedo se hanno usato violenza contro di loro. “No, solo qualche gesto… Ma qualcuno ha sparato, non lontano. Abbiamo visto i lampi dei fucili a ripetizione, ci siamo messi a correre”. Gli chiedo se sa il perché di quegli spari, ma sorride, scuote la testa. “E dopo, quando siete arrivati in Turchia?”. “La gente che abbiamo incontrato è stata gentile, non tutti, ma la maggioranza sì. Ci hanno dato da bere, da mangiare. La polizia turca ci ha sistemati su un autobus per Izmir, ventiquattro ore di viaggio”. E da Izmir? Come avete fatto a trovare un imbarco? “Altri siriani ci hanno detto dove andare, abbiamo incontrato gli scafisti, pagato ottocento dollari per un posto a bordo”. Su che barca? “Un gommone di nove metri, eravamo quarantacinque” ma un altro ragazzo lo corregge: “Quarantasei”. Faccia paffuta, sguardo buono, non chiedo il suo nome. Un miliziano dell’Isis ha ucciso sua sorella a colpi di mitra, ma oltre un accenno a questa tragedia non fa. Racconta della traversata: “dovevamo togliere l’acqua da dentro con un secchio continuamente, senza mai fermarci. Entrava in grande quantità, perché eravamo al limite con l’affondamento. Eravamo zuppi, faceva freddo. Ma almeno io sono riuscito a farcela al primo colpo. Lui è stato meno fortunato”. Accanto indica un ragazzo magro, il più giovane del gruppo, Rashid, 21 anni, studente di economia, sguardo vispo, occhi rapidi, intelligenti. Lui ci ha provato addirittura otto volte, e in sette tentativi la guardia costiera greca li ha rimandati indietro. “L‘ottava volta lo scafista voleva farci ripagare il prezzo,” racconta “ci siamo azzuffati, avevano dei coltelli, ma noi eravamo tanti, e alla fine ci hanno imbarcati. E ce l’abbiamo fatta. Mi chiedo se i tentativi fatti a vuoto non fossero un caso…”. Ridono tutti, scambiano qualche battuta in arabo. Lo prendono in giro, credo, per quello che ha appena detto.
I greci che hanno trovato sulle coste di Lesvos li hanno aiutati, offerto cibo e acqua, indicato la via del porto. Anche i pochi poliziotti greci che hanno visto, solo in due occasioni, sono stati cortesi. In effetti in tre giorni non ho mai visto un gendarme, a parte da lontano, un’auto della polizia con i lampeggiatori accesi. In porto ci sono una decina tra pilotine e corvette di capitaneria e marina militare, ma oltre a questo non c’è alcun servizio d’ordine sull’isola, dove sta il grosso delle migliaia di migranti che quotidianamente si danno il cambio tra chi riparte e chi arriva. Non si avverte alcun bisogno di reprimere o arginare, non si ascolta alcuno schiamazzo, nessun litigio, nessun gesto violento. C’è più confusione a Civitavecchia, ad agosto, per imbarcarsi verso la Sardegna.
Penso che infatti questi non sono migranti, è improprio chiamarli esuli, disperati, perché sono viaggiatori. Hanno tutti deciso di andare via, hanno del denaro con sé, hanno una meta (“amici siriani in Svezia, che ci aspettano, che sia fatta la volontà di Allah”), si siedono a centinaia sulle banchine, ma altrettanti popolano i locali del porto, che stanno facendo affari d’oro, mangiano qualcosa, bevono, usano il wifi. Sono vestiti ordinati, per quello che consente un simile viaggio, si lavano alle fontanelle, o direttamente in mare. Ho più macchie e buchi io nei pantaloncini che uso per navigare di loro che viaggiano da cinque giorni. Mi guardo e mi vergogno un po’.
Mi raccontano che a Damasco ci sono spesso attentati, bombe, e che in molte parti del paese regna la violenza. Per questo sono partiti. “Qualunque cosa è meglio di quella vita. Stasera andiamo ad Atene con la nave, poi andremo in Macedonia, poi in Serbia e poi vediamo. Pensavamo all’Ungheria, ma lì c’è un governo di destra che non fa passare nessuno. Per chi va in Germania non è molto difficile a quel punto. Per chi va in Scandinavia c’è ancora molta strada”. Stimano quattro settimane di viaggio almeno. Sorridono, come a dire “stiamo freschi, hai voglia la strada che manca ancora”.
Ci salutiamo. Mani sul cuore, invocazioni alla sorte e a Dio. Anche se mi pare che di Dio qui non ci sia molta traccia. Mentre di coraggio e voglia di vivere ne vedo dovunque.
Poco dopo gli sguardi s’incrociano con Ruhollah, che viaggia con la nipote. Sono entrambi afgani, due facce dolci, gentili, la ragazzina avrà tredici anni, lui ne ha diciannove. “Siamo afgani ma siamo dei senza terra”. Mi spiega che sono dovuti fuggire in Iran perché i Taliban li avrebbero uccisi. “Noi siamo mussulmani sciiti, e i Taliban dicono che se uccidi sette sciiti vai in paradiso. Mi chiedo dove stia scritta una bestemmia del genere. Non certo nel Corano. Io il Corano l’ho letto tutto”. Ruhollah è un ragazzo educato, parla un ottimo inglese, è vestito molto bene, ha una camicia bianca linda. Mi spiega che tutta la loro famiglia ha studiato, ma che in Iran erano dei senza terra, senza patria, senza diritti. “Siamo dovuti fuggire, purtroppo non insieme, in momenti diversi. Io e Perisa abbiamo valicato il confine con la Turchia a est di Aleppo, circa sessanta chilometri a est, camminando quarantotto ore senza fermarci mai, notte e giorno. Lei era sfinita, e io anche ad essere sinceri. Chi ci ha condotto ci ha dato bastonate per farci muovere quando ci sedevamo per un momento. Poi quando abbiamo incontrato i turchi, loro sono fuggiti”. Gli chiedo quanto hanno dovuto pagare. “Ottocento dollari a testa”. “Di che nazionalità erano i frontalieri?” “Siriani. Uno forse iracheno”. “E i turchi come vi hanno trattato?” “Molto bene. Curdi e turchi ci hanno aiutato, e non solo la gente comune, anche i militari. Ci hanno consegnato un pacco con dentro acqua e viveri e ci hanno messi su un autobus per Ankara. Poi siamo arrivati a Istanbul. Lì abbiamo incontrato gente che ci ha spiegato come fare per la traversata. In tutto abbiamo viaggiato dieci giorni per arrivare qui a Lesvos”. Le storie coincidono con quelle dei ragazzi siriani, ma il prezzo pagato per la parte a mare è maggiore: mille dollari a testa. Ruhollah mi spiega che è stato terrorizzato fino all’ultimo, perché “a bordo di un gommone di non so quanti metri, ma non tanto grande, eravamo in trentacinque. Io ho pensato che saremmo morti tutti. C’era anche un bambino piccolo, non so, forse di un anno appena, che piangeva, e Perisa stessa era in lacrime. Era notte, non si vedeva niente. Chi non aveva le scarpe sugli scogli si è fatto tagli profondi. Poi, grazie alla volontà di Dio, siamo arrivati qui. Adesso finalmente siamo in salvo, e ora è anche tutto legale”. Mi colpisce questa affermazione. Gli chiedo se abbiano documenti o altro per l’identificazione: “No, nessun documento”. E come fate allora? “Siamo rifugiati, il diritto internazionale è molto preciso su questo”. Sto parlando con un migrante che conosce il diritto internazionale a diciannove anni. “Io studio legge, cioè, studiavo, ero al primo anno, poi sono dovuto partire. Ma spero di ricominciare appena arrivo in Svezia”.
Stasera partirà anche lui, partiranno tutti, per lasciare posto sui moli ad altre migliaia in arrivo. Li guarderò passare a bordo del traghetto, che sfila avanti piano a poche decine di metri da Mediterranea e poi passa su avanti tutta con la prua a sud. Speriamo vedano che li saluto, che auguro loro buon vento. Tutti in viaggio per un’altra vita.