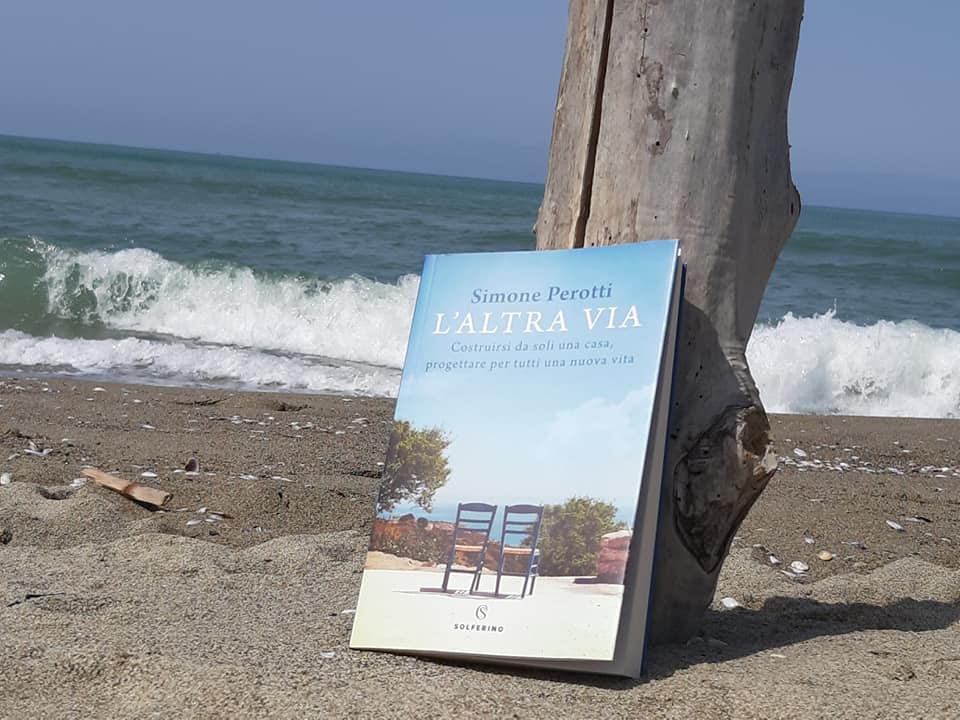A un certo punto è nata, gloriosa, nuova, eccitante, la “voce popolare”. Il consiglio di chi aveva già usato quel prodotto, o la sapeva lunga per qualche ragione. L’opinione da bar, o che apprendevamo da un collega, da un amico, da qualcuno che consideravamo esperto. La stessa. Ma molto, molto più grande! Planetaria! Fin anche in tutte le lingue, ormai tradotte (bene? male?) da un algoritmo, dunque comprensibili a tutti. Universali quindi! La voce popolare del mondo sotto forma di commento, valutazione, con tanto di stelle, tre, cinque, a significare il “verbo di Dio”, perché il popolo è sovrano, o almeno, lo è diventato online, perché off line non lo era mica più tanto… Ma è tornata a contare l’opinione della gente. La gente, come riempie bene la bocca questa parola n’è? Ecco finalmente estinta la truffa delle aziende! Mai più potranno fregare il cliente. Ecco svelate tutte le magagne dei prodotti, tutti i problemi dei servizi, e tutto quel che c’è da sapere, perché è “la gente che fa la storia (la storia siamo noi) e nessuno la può fermare.
A un certo punto è nata, gloriosa, nuova, eccitante, la “voce popolare”. Il consiglio di chi aveva già usato quel prodotto, o la sapeva lunga per qualche ragione. L’opinione da bar, o che apprendevamo da un collega, da un amico, da qualcuno che consideravamo esperto. La stessa. Ma molto, molto più grande! Planetaria! Fin anche in tutte le lingue, ormai tradotte (bene? male?) da un algoritmo, dunque comprensibili a tutti. Universali quindi! La voce popolare del mondo sotto forma di commento, valutazione, con tanto di stelle, tre, cinque, a significare il “verbo di Dio”, perché il popolo è sovrano, o almeno, lo è diventato online, perché off line non lo era mica più tanto… Ma è tornata a contare l’opinione della gente. La gente, come riempie bene la bocca questa parola n’è? Ecco finalmente estinta la truffa delle aziende! Mai più potranno fregare il cliente. Ecco svelate tutte le magagne dei prodotti, tutti i problemi dei servizi, e tutto quel che c’è da sapere, perché è “la gente che fa la storia (la storia siamo noi) e nessuno la può fermare.
Solo che piano piano si è capito meglio qualcosa. E cioè che la gente non è il verbo, anzi… Non mi sono mai fidato del parere degli altri, per un semplice ragionamento logico: sapevo chi fossero? Conoscevo cosa volessero? So come la vedono su un argomento, su un altro? Con quali strumenti critici, quale esperienza? Non dovrei prima sapere questo, per poi tenere in considerazione la loro opinione?
Non ho mai guardato i giudizi degli utilizzatori finali. Anzi, ho sempre fatto un lavoro opposto: leggere i commenti ai prodotti che usavo già, quelli che conoscevo bene, per studiare la gente. In pratica ho fatto come i salmoni, che vanno controcorrente: non le opinioni delle persone per scegliere i prodotti, ma le opinioni sui prodotti per capire le persone.
E ho scoperto ciò che sapevo già: che quei giudizi non sono i miei, viaggiano per stereotipi che non ho (o che ho anch’io), con un occhio al valore del denaro che non è quasi mai il mio; con un’idea sull’uso che non pratico; con speranze e sospetti che non provo. In ogni caso quel coro è fatto da voci diverse dalla mia: c’è quello che considera uno sbuffo di vapore della macchinetta del caffè “un’esplosione”, e lo scrive dicendo “non compratela; c’è chi mette una stella perché il pacco gli è arrivato aperto (ma che c’entra col prodotto?); c’è chi considera “uso professionale” quel che io considero hobby, e viceversa; c’è chi parla di cose che non ha mai visto, sentito, praticato; c’è chi definisce “pulita” una stanza che io giudicherei un porcile, perché a casa siamo abituati a due forme d’igiene diversa; che chi dice che oggi c’è in atto una dittatura (lo dico solo per esempio, non vi arrabbiate); c’è chi la sa lunghissima, ma sta accanto a chi non ne sa nulla, perché sul web “uno vale uno”, solo che la loro è una “media a due”.
Ma c’è dell’altro. Si è saputo che ci sono scrittori che comprano like, stelle, commenti, e finiscono primi in classifica. Poi ristoratori che organizzano decine di recensioni negative per il concorrente che hanno accanto. Poi negozianti che fanno sconti se fai la recensione. Poi alberghi che ti ridanno la caparra solo se gli “dai” cinque stelle. E poi recensioni di posti mai visti, da non viaggiatori, di alberghi mai frequentati, libri mai letti, prodotti mai acquistati, solo per denaro, sempre per interesse. “In quel ristorante si mangia male” detto da uno che non sa fare due uova al tegamino.
Insomma, diciamocelo francamente: la “vox populi” è un disastro. Pessima e basta, quando va bene, fuorviante per dolo quando va male, dannosa e truffaldina in numero crescente. Perché coi like si fanno i soldi: li fanno le aziende, i clienti, e anche chi stava solo passando di là. Influencer prezzolati dai produttori, clienti non lucidi o che razzolano centesimi di euro. E tu, che stai solo cercando un phon, o una spillatrice, o una motosega, o un romanzo… costretto a passare ore a leggere banalità, o falsità fuori controllo, opinioni mitizzate dalla tecnocrazia, e finirai col prendere qualcosa di sbagliato seguendo il giudizio sbagliato di un sistema sbagliato.
In tutto ciò va messa anche la sottile coercizione dei “tutorial”. Pagati anche loro, ormai in larga misura; o frutto del narcisismo di incapaci, che non mostrano tutto il video, solo quello che funziona; oppure di improvvisati, quelli dei sentito dire, più bisognosi di te che hai bisogno di loro. Il web esprime expertise generalizzate, ormai, e non in quanto expertise, ma in quanto web. Se mostri “come si fa” su qualche sito o social… sei un maestro. Tanti proveranno, e attribuiranno a loro stessi il fallimento, a te i meriti. Una deregulation dell’autostima che non genera techné, cioè che lascia ignoranti, un po’ come quando raggiungi una località seguendo il gps: sei arrivato, è vero, ma non sapresti mai rifare quella strada. Perché non l’hai scovata, l’hai solo eseguita. Non l’hai cercata, te l’hanno mostrata. Non hai deciso, hai obbedito.
C’era una volta (come nelle favole) l’uomo che doveva costruire una propria opinione usando segnali deboli, cercando di immaginare, facendo scommesse senza rete, o dando credito solo a Mario, l’artigiano che ha la bottega in fondo al paese. Lui sì che si sapeva per certo quanto fosse bravo. Altrimenti si rischiava. Che brivido questa parola: rischiare. Si rischiava un’idea, una visione-delle-cose, perché ti eri convinto che fosse proprio così, lo “volevi”. Ci si struggeva per capire non “com’è lui” (il prodotto) ma chi sei tu che lo vuoi, cosa devi fare per usarlo, cosa ti serve per il tuo lavoro, sperando di trovare qualcosa in una giungla tua, quella dei dubbi e delle certezze, sbagliando da solo, perché per farlo non c’era bisogno di alcun aiuto, eravamo già bravi abbastanza. Tempi in cui bisognava “sapere in una stanza dov’è il nord”, e che uomo si stava girando su se stesso per indicarlo. E erano bei tempi, oh sì, perché chi sbagliava aveva comunque fatto un passo avanti. Aveva capito se non altro se stesso, cioè chi era “l’uomo della scelta”, magari sbagliata ma propria. Quell’uomo si era sforzato di “farsi un’idea originale” ad alto tasso di immaginazione, e quando ci azzeccava, provava orgoglio vero.
Non come la sensazione di essere tutti inevitabilmente dei coglioni… cioè quella che ci pervade, quasi sempre, oggi.